Né destra, né sinistra. Intervista a Franco Cardini
23/09/2008
1. Professor Cardini, qual è la sua opinione sul conflitto russo-georgiano?
Da ormai molto tempo il governo georgiano aveva fatto la sua scelta: schierarsi con l’ “Occidente”, accedere all’Unione Europea e insieme (un’ “accoppiata” ormai considerata come naturale e necessaria, e che a me sembra demenziale) alla NATO. Non desidero entrare sulle ragioni dell’antichissimo rancore dei georgiani nei confronti della Russia zarista, dell’Unione Sovietica e della Russia egemone della CSI. Molte di tali ragioni sono ineccepibili, qualcuna sacrosanta. Ma è non meno indubbio che da oltre un secolo Russia e Georgia sono straordinariamente legate tra loro, oltre a connessioni storico-antropologiche ancora più antiche. Come non c’è dubbio che i migliori cespiti economici georgiani (il vino, i prodotti agricoli, il turismo balneare sul Mar Nero, quello invernale in Caucaso) avevano nel mondo russo il principale referente e il cliente privilegiato. D’altro canto, non meno importante era e resta la questione dei confini e della loro reciproca sicurezza, così come quella delle minoranze dell’area caucasica. La Russia è stata costretta a difendersi da una preoccupante strategia d’accerchiamento: la NATO (quindi gli USA) hanno piazzato dappertutto sui confini russi missili a testata atomica, dalla Polonia alla Bulgaria alla Romania alla Georgia stessa. Una provocazione intollerabile: in termini diplomatici “tradizionali”, un casus belli.
2. Secondo lei l’atteggiamento dell’Unione Europea nei confronti della Russia è stato equilibrato?
Una battuta, per cominciare. Qualche mese fa, in occasione della crisi kossovara, i governi europei e soprattutto la stragrande maggioranza dei mass media dei nostri paesi, con qualche sfumatura, non ebbero pudore ad abbracciare immediatamente la causa dell’indipendenza degli albanesi-kossovari dalla Serbia-Yugoslavia. Ma la situazione del Kosovo albanese era ed è del tutto parallela e speculare rispetto a quella dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud. Con quale spudoratezza, ora, si abbraccia con altrettanta sicurezza la causa del microimperialismo etnico georgiano? Perché quel ch’era pochi mesi valido, a nostro avviso, per i kossovari albanesi non deve esserlo, ora, per abkhazi e osseto-meridionali?
Ma la spiegazione di queste miserie logiche sta purtroppo nella politica. Come Lei sa, non esiste l’Europa: esiste l’Eurolandia, la Terra dell’Euro governata da organizzazioni come la Banca Centrale Europea, delle quali gli organi politici (Consiglio d’Europa, Commissione Europea, parlamento Europeo ecc.), tutti in ambiguo rapporto con i vari governi nazionali europei che non hanno mai voluto rinunziare a una parte della loro sovranità per costituire una Federazione o una Confederazione vera e propria, sono poco più che dei “comitati d’affari”. L’Unione Europea non ha né una politica estera, né una forza militare comune: ha quindi risposto alla recente crisi caucasica come negli Anni Novanta aveva risposto a quella balcanica e pochi mesi or sono a quella kossovara. Cioè malissimo, prendendo sostanzialmente ordini dagli Stati Uniti tramite la NATO. Il che non è strano, considerato che l’Europa è occupata e controllata da un esercito straniero e gode pertanto di sovranità limitata (oltre 100 basi militari statunitensi o NATO nella sola Italia: concorriamo alle loro spese di mantenimento, ma non le controlliamo).
Quella europea è stata comunque una politica forse obbligata, comunque sconsiderata, radice della quale è il pregiudizio che l’Europa debba schierarsi sempre e comunque con “l’Occidente” contro la Russia. In realtà, l’Europa avrebbe semmai molti e validissimi motivi politici, storici, culturali, economici e produttivi (e penso anche al petrolio e al metano) per stabilire stretti rapporti proprio con la Russia.
3. A suo avviso il conflitto tra Russia e Georgia potrebbe essere la scusa che l’amministrazione Bush cercava per bombardare l’Iran?
Rovescerei la domanda: non credo ci sia dubbio che la sconsiderata politica di Bush e dei suoi satelliti, l’accerchiamento della Russia, serva al tempo stesso a piazzare basi che al momento opportuno potrebbero colpire lo stesso Iran. Quelle georgiane erano, a quanto sembra essere emerso anche da rapporti di osservatori internazionali, appunto deputate anche a questo ruolo. Una politica aggressiva che lascia interdetti per spregiudicatezza, imprudenza e prepotenza.
4. Passando a tutt’altro argomento, Professor Cardini, lei in gioventù è stato iscritto al Movimento Sociale Italiano e poi alla Giovane Europa, il movimento transnazionale di estrema destra fondato da Jean Thiriart. Al giorno d’oggi si sente ancora un uomo di “destra”?
E’ sempre stato difficile, ma ormai è impossibile definire sul serio che cosa siano la “destra” e la “sinistra”. Aveva ragione Giorgio Gaber.
Comunque, per quanto riguarda certe mie opzioni, specie in politica socioeconomica, a parte l’essere di destra o di sinistra, io mi sono sempre sentito, e da parecchi anni, piuttosto di stare a sinistra; e mi succedeva del resto già quando ero un giovane missino. Eppure, non mi sono mai granché inalberato quando mi definivano “di destra”, e mi succede ancora di tollerarlo, magari replicando con qualche distinzione a mio avviso legittima.
Cercherò di spiegarmi. “Destra” e “sinistra” hanno una lunga e complessa storia, dalla fine del XVIII secolo ad oggi: e che la destra valuti soprattutto la “persona” laddove la sinistra privilegia “l’individuo” e “le masse”, che la destra sia per la “comun ità” e la sinistra invece per la “società” (la famosa dicotomia di Tönnies), che la destra privilegi la “libertà” e la sinistra “l’eguaglianza” ( o quanto meno la “giustizia”), che la destra sia per il radicamento e la nazione e la sinistra per il cosmopolitismo e l’internazionalismo, che la destra sia “conservatrice” e la sinistra “progressista”, sono coppie d’opposti tutte plausibili ma in fondo lasciano il tempo che trovano: e, nel concreto processo storico, vengono sovente disattese e contraddette. Era di sinistra Guevara, e magari perfino Stalin? Era di destra Peron, e magari perfino Mussolini? Allora, Tanto vale tornare al cane che è di destra e il gatto di sinistra, al bagno in vasca che è di destra e la doccia di sinistra.
Quanto a me, per dire la verità, io mi sono sentito sempre “di destra” esclusivamente nel senso che mi ha insegnato tra 1958 - quando l’ho conosciuto – e 1966 - quando la tubercolosi contratta in guerra l’ha portato via -, uno dei miei più cari Maestri, Attilio Mordini, studioso tradizionalista, cattolico e terziario francescano. Per Mordini, essere “di destra” aveva un senso metafisico, metastorico e metapolitico: significava, per ogni uomo, ancorarsi alla propria Tradizione, le scaturigini della quale sono sempre divine. Mordini, filologo e filosofo del linguaggio, insegnava che le lingue hanno origini non “naturali” e “umane”, bensì metafisiche e sacrali; e che ogni Tradizione è sacra e ogni popolo, ogni gruppo umano storicamente qualificato deve tenersi fedele alla propria. Le Tradizioni dialogano senza dubbio, e sono portatrici tutte di una Verità analoga, anzi omogenea. Ma non spetta agli uomini trovare la chiave di questa analogia, di questa omogeneità: per quanto non sia illecito cercarla con gli strumenti del sapere gnostico o di quello mistico. La Tradizioni, tutte collegate tra loro, non comunicano orizzontalmente tra loro, bensì verticalmente, in Dio. Era lo stesso insegnamento di Nicola Cusano. Nella tradizione occidentale, la fedeltà alla Tradizione si traduceva, storicamente, nella fedeltà ai valori cristiani, gerarchici e solidaristici dell’Europa prerivoluzionaria: quindi nell’opposizione rispetto ai due massimi nemici di essa, l’individualismo e il culto del danaro per il danaro, del progresso per il progresso. Il punto è che, sul piano storico, almeno dalla metà dell’Ottocento la “destra” si è sviluppata, come “luogo” d’una tendenza politica, proprio come vocazione all’individualismo, alla produzione e gestione della ricchezza, alla venerazione del progresso: danaro e progresso sentiti non già come mezzo bensì come fine, ma un fine che per sua natura escludeva qualunque altri fini e non fissava neppure un termine per se stesso. Individualismo e meccanismo produzione-profitto-consumo come mète costanti ma inesauribili del genere umano. Rispetto a questa “destra” liberale, liberista, progressista, materialista (anche se cristiana sotto il profilo formale), la Destra tradizionalista non può che sentirsi agli antipodi: anzi, sovente molto più vicino ad alcune aree della sinistra, le quali propongono obiettivi almeno in superficie e in apparenza più vicini a lei, quali il rispetto delle culture folkloriche, il solidarismo, la giustizia sociale. Il Cristo Re della Destra e il “Cristo socialista” di certe aree della sinistra si somigliano tra loro almeno quanto consenta ad entrambi di riconoscersi nella lotta contro l’Anticristo turbocapitalista; e se l’Anticristo turbocapitalista affascina alcune Chiese cristiane storiche, tanto peggio per quelle Chiese. Vi sono poi idee come quella di “Nazione”, nata alla fine del Settecento “a sinistra” (per fronteggiare il Trono e l’Altare) e finite “a destra”, ma in un tipo di “destra” che, dall’esperienza bonapartista al saintsimonismo al socialismo utopistico (soprattutto Sorel) al sindacalismo rivoluzionario, è sempre stata permeata di valori sociali. Il fascismo, per esempio, è nato da questi valori, anche se essi forse non si sarebbero mai “innescati” nella storia senza la tragedia della falsa e ingiusta pace di Versailles del 1918.
Quanto a me, ogni uomo ha la sua storia. Sono arrivato al MSI in calzoni corti, tredicenne, nel 1953: erano i tempi di Trieste italiana; poi ci sono rimasto a causa del 1956 e della sollevazione ungherese. La mia educazione cattolica e l’amicizia stretta con il gruppo di Attilio Mordini mi hanno subito vaccinato da liberismo, nazionalismo e giacobinismo, i pericoli della pur schizofrenica destra neofascista missina; l’antisemitismo, eredità ambigua e rivoltante dell’ultimo fascismo, mi è sempre stato estraneo e l’ho sempre avvertito come repellente (anche quando, prima dell’affare Eichmann, in realtà se ne parlava pochissimo), grazie soprattutto sia appunto alla mia educazione cattolica, sia al magistero di Attilio Mordini che aveva intrapreso con grande ammirazione lo studio della Kabbalà, era membro di un’associazione fiorentina d’amicizia cristiano-ebraica e profondamente radicato nella rivendicazione dell’eredità ebraica come seme fecondo del cristianesimo. Semmai, dell’esperienza fascista m’interessavano le “fronde”, che sovente avevano inclinato verso simpatie socialiste, anarchiche o addirittura comuniste; penso soprattutto all’esperienza di Berto Ricci e a quello che uno studioso contemporaneo ha definito il suo “fascismo impossibile” (a mia volta, ho preferito chiamare quella mia esperienza adolescenziale un “fascismo immaginario”). Condividevo questi gusti e queste tendenze con un piccolo gruppo di amici. A questo ambiente di margine, ma culturalmente vivo e fecondo, debbo ovviamente l’uscita nel 1965 dal MSI e l’incontro – nell’ambito del gruppo europeista di Jean Thiriart – con la complessa e contraddittoria produzione intellettuale dei “fascisti” francesi, “fascisti” senza dubbio alquanto a modo loro e in molti modi tra loro differenti e opposti; e, tra tutte quelle forme, la più vicina e congeniale alla mia formazione fu il “socialismo fascista” ed europeista di Pierre Drieu la Rochelle. Ho ormai superato da oltre un quarantennio queste forme d’ispirazione e di sollecitazione, ma riconosco che ad esse debbo ancora molto: anzitutto il mio radicale, incrollabile, rigoroso europeismo. E’ ovvio che questa Unione Europea, burocraticamente oppressiva e politicamente inesistente, non mi piaccia: ma a contribuire alla costruzione di un’autentica Patria Europea non rinunzierò mai.
5. Lei si ritiene anticapitalista?
Ho già risposto implicitamente poco fa. Sono decisamente solidarista e apprezzo la dottrina sociale della Chiesa; se non sapessi che il socialismo è in realtà qualcosa di molto di più e di molto diverso rispetto a una semplice teoria socioeconomica, non esiterei a definirmi socialista. Ciò dichiarato, debbo tuttavia aggiungere che come forma storico-sociale il capitalismo, quando e nella misura in cui accetta di farsi “civico” (secondo del resto la “classica” indicazione di John StuartMill), può convivere e collaborare ad esempio con lo “stato sociale”, dimensione politica e istituzionale che una seria e sana destra politica dovrebbe difendere strenuamente, come sua ultima vera ridotta, contro l’offensiva delle lobbies multinazionali senza volto, senza patria e senz’altro scopo che non sia il profitto. Mi sembra invece che la stessa sinistra stia abbandonando questo spalto, correndo dietro ancora una volta – è fenomeno frequente negli ultimi anni – alla destra nella politica delle “privatizzazioni”, della quale in genere diffido e che in alcuni casi specifici mi sembra davvero sconsiderata.
6. Crede che la debacle elettorale della sinistra radicale (ma anche dell’estrema destra) alle ultime elezioni politiche sia il frutto dell’americanizzazione della società italiana?
Premesso che è bene non nasconderci dietro a un dito e non tacere che la débacle delle “estreme” radicali (nel senso etimologico dell’aggettivo) è stata causata anche dalla miseria del livello dei loro quadri dirigenti ed esecutivi, è chiaro che è un po’ così: anche se esiterei a chiamarla, riduttivamente, “americanizzazione”. Il fatto è che oggi le società civili e le opinioni pubbliche dei vari paesi europei sono ridotte a larve miserabili, a sacche vuote prive di qualunque informazione sulla realtà che le circonda e di qualunque aspirazione: che poi esse siano preoccupate dai segni della crisi incipiente, è prova ulteriore della loro vuotezza. Dinanzi al fallimento gigantesco del turbocapitalismo, che sta già avanzando a gran passi e che si annunzia ovviamente come crisi che colpirà prima e soprattutto i ceti più fragili, si sta reagendo o con la totale “demobilitazione delle masse” (al contrario di quel che facevano i grandi totalitarismi del XX secolo), con l’anestetizzazione totale a base di culto delle libertà individuale e dei consumi nonché di forti dosi di “società-spettacolo” e di “politica-spettacolo” che riducono i cittadini a spettatori e a consumatori, oppure con le colossali e ben congegnate campagne imbonitrici che mettono in guardia contro pericoli inesistenti (caso-limite il terrorismo islamico) e ne assumono anzi il pretesto per la riduzione delle libertà civili effettive (si pensi allo scandaloso Patriot Act negli Stati Uniti). E’ chiaro che una società così condizionata “serra al centro”, nell’illusoria sicurezza della “pace” e della “sicurezza”, magari demonizzando qualunque prospettiva alternativa, trattata da “male assoluto”. Destra e sinistra finiscono con il somigliarsi, propongono entrambe “rilancio”, “ripresa” e appunto “pace” e “sicurezza”, e si tengono a galla offrendo ai poteri che davvero contano (le varie lobbies) i servigi di un “comitato d’affari” costituito da uno staff politico e parlamentare oligarchico, garantito da competizioni elettorali sempre più addomesticate (si pensi alle ultime elezioni politiche in Italia, con liste “blindate” dalle singole segreterie e quindi un parlamento designato da ciascuna di esse, per quanto poi formalmente legittimato da un fiacco voto popolare). I politici divengono in tal modo sempre più la cinghia di trasmissione dalla volontà delle lobbies finanziarie e imprenditoriali alle sedi del potere legislativo ed esecutivo incaricate di elaborare e legittimare provvedimenti in linea con gli interessi di quelle stesse lobbies.
7. Qual è la sua opinione sulla xenofobia e sul razzismo? Secondo lei è motivata la paura della cosiddetta “invasione islamica”, tesi sostenuta da vari movimenti della destra radicale e dalla Lega Nord?
La xenofobia (cioè la paura del “diverso”, dell’ “estraneo”, è fenomeno che infallibilmente si verifica, in varia misura, nelle società coinvolte in rapidi e massicci fenomeni di mutamento sociodemografico: si fonda su istinti in fondo “naturali” e, a piccole dosi, è come i germi del morbillo o della scarlattina: finisce col creare una lieve infezione che alla lunga ha effetto immunizzante. Se le dosi si fanno massicce o i tempi di esposizione al contagio si fanno intensi, il discorso cambia. Sappiamo bene, da molti e illustri esempi storici, che la “paura dell’Altro” (l’ebreo che ti seduce la donna, il marocchino che ti ruba il lavoro e così via…) servono da tempo come alibi per impedire che la gente si renda conto con maggior chiarezza e precisione delle peraltro complesse dinamiche sociali che dominano i processi storici in tempi di crisi. Un esempio. I gruppi di estrema destra o della Lega Nord sono sostanziosamente finanziati da vari anni, tra l’altro, da imprenditori di pochi scrupoli i quali chiudono (contro la legge) le loro fabbriche in Italia, vanno a riaprile in luoghi dove la manodopera è molto più a buon mercato (la Romania, l’Albania ecc.) e in questo modo sottraggono – cioè, letteralmente, rubano – lavoro agli italiani e al tempo stesso si arricchiscono sfruttando la sottopagata manodopera euro-orientale: dopo di che, hanno interesse a che i responsabili della rarefazione del lavoro in Italia siano identificati negli extracomunitari. E’ d’altronde un dato obiettivo che l’alto afflusso di extracomunitari clandestini crea ogni sorta di problemi e concorre a far crescer varie forme di microdelinquenza. Si deve lottare contro questi fenomeni con rigore: e le leggi al riguardo ci sono; se non ci sono, si possono sempre fare. Chi parla al riguardo di “tolleranza zero” esprime un parere assurdo: dal momento che dovrebbe essere sottinteso che, nei confronti di qualunque forma di delinquenza, la tolleranza in un stato di diritto deve per forza essere sempre “zero”. Quanto all’invasione islamica, semplicemente: non esiste. In Italia, paese di sessanta milioni di abitanti, i musulmani non sono nemmeno un milione: dunque non arrivano al 2% , di cui circa 10.000 (vale a dire l’1% di loro) sono italiani convertiti, che per il fatto di essere diventati musulmani non hanno certo cessato di essere “occidentali”. Molti di questi musulmani sono cittadini italiani, magari da poco, hanno casa, famiglia, lavoro; altri sono immigrati in regola con la legge. Una minoranza tra loro fa attività sociale, culturale, e in pochi e ristretti casi (noti e controllati) anche proselitistica. Da sette anni, cioè dall’indomani dell’11 settembre del 2001 a oggi, i casi di musulmani fermati per attività terroristica si contano sulle dita delle mani, e sono stati poi quasi tutti regolarmente rilasciati senza che al loro carico emergesse un minimo d’indizio concreto. Nel nostro paese, non c’è mai stato alcun attentato che sia stato fatto risalire a una matrice “islamico-fondamentalista”. Ci sono imprenditori musulmani e qualche intellettuale musulmano, ma non mi sembra che la loro attività sia particolarmente presente sul nostro territorio. A che cosa allude chi parla dei “minareti” che andrebbero a “disturbare” il nostro paesaggio? Di moschee con minareto, in Italia c’è solo quella di Roma, che non disturba un bel niente: anzi, è architettonicamente apprezzabile. Il paesaggio lo hanno distrutto da mezzo secolo a questa parte i nostri speculatori: basti vedere come sono ridotti alcuni tratti del nostro litorale e alcune nostre periferie cittadine. Io vado a messa ogni domenica: ma, siccome per il mio alvoro mi muovo molto, frequento differenti chiese in varie città d’Italia. Non mi è mai capitato, in tanti anni, di trovarmi davanti a un picchetto di musulmani che distribuisse materiale proselitistico. Le nostre tradizioni si vanno autodistruggendo, è vero: ma si tratta di un processo lungo, iniziato da molto tempo. L’Islam non c’entra. Le tradizioni non si distruggono dall’esterno, franano sempre dall’interno. Del resto, l’islamofobia è un po’ passata di moda: i centri che la promovevano ora hanno interessi di altro genere, guardano alla Russia e alla Cina. Sempre cercando il Nemico Metafisico da sbattere in prima pagina per impedire alla gente di accorgersi che il vero pericolo, il vero nemico, s’identifica con quelle forze che ormai da anni gestiscono il turbocapitalismo e la speculazione finanziaria; quelle stesse che, ora che il petrolio sta esaurendosi, sono già partite addirittura all’appropriazione e alla privatizzazione dell’acqua.
8. L’intellettuale transalpino Alain de Benoist ha sostenuto molte volte del concetto di Impero. Secondo de Benoist la crisi dello Stato Nazione, troppo grande per rispondere alle aspettative quotidiane della gente e troppo piccolo per far fronte alle problematiche che si sviluppano oramai su scala planetaria, richiederebbe di ripensare l’Europa in termini Imperial-federali. Qual è la sua opinione sul tema dell’Europa Imperiale?
“Impero” è una gran bella parola, ma temo che la gente la confonda con il suo pseudosemiomonimo, “imperialismo”, che al contrario è bruttissima. L’empire, c’est la paix, diceva Napoleone III: ma alludeva alla repubblica retta da un monarca e da una dinastia in quanto garanzia contro il disordine. Oggi, intenderei la parola “impero” – in armonia del resto con i suoi esempi storici, o alcuni fra essi: l’impero romano, la “monarchia di Spagna” – nel senso di un’auctoritas suprema e indiscussa che sia giudice e regolatrice d’una pluralità di soggetti diversi tra loro, ciascuno retti da proprie istituzioni e armonicamente conviventi. In questo senso, l’ “impero” sta all’esatto opposto delle compagini magari eterogenee, ma tenute insieme dall’autorità e dalla forza di uno stato egemone, che naturalmente tende a gestirne politica ed economia secondo i suoi interessi. “Europa Imperiale” è un’altra bella espressione: sarebbe stato l’ideale – credo sostenuto in buona fede – da Napoleone: un’unione di differenti nazioni sotto l’egida di una potenza garante e protettrice che però accetti di non giocare (magari passato il momento della necessaria emergenza) un ruolo egemone. Ma quel disegno si è infranto ancora prima di Waterloo: è morto nelle pianure russe e tra le cannonate della battaglia di Lipsia. Una potenza egemone è comunque necessaria, di solito, a creare formazioni federali o confederali: si pensi alla storia dell’Italia e della Germania nell’Ottocento, con i loro Piemonte e Prussia. Ma, fenomenologicamente, non è sempre detto. Anche Hitler aveva un’idea “napoleonica” dell’”Europa Imperiale”, l’idea alla quale fu guadagnato Drieu La Rochelle: ma il suo impero era senza dubbio più nettamente e pesantemente egemonia germanica di quanto Napoleone non concepisse l’egemonia francese. Thiriart, neobonapartista e anche un po’ filohitleriano (quanto meno sotto il profilo del suo europeismo), pensava in termini un po’ astratti a una “Europa-Nazione”. Ma il suo concetto era rozzamente elaborato e stoticamente poco realistico: gli statunitensi possono pensare a se stessi come alla “Nazione americana”, ma i singoli states hanno una storia diversa, più breve e fragile di quelli europei; e c’è inoltre un sostanziale monolinguismo, valore importantissimo. Pensare a un’ “Europa-Nazione” è impossibile. Credo si possa invece pensare ad essa come a un Grossvaterland che sintetizzi e riassuma, senza annullarli, i vari Vaterländer nazionali o anche etnici. Ma per questo è necessaria una struttura federale o confederale: l’Unione Europea non è nulla di tutto questo: e non lo sarà mai finché i singoli stati non si decideranno a creare una vera compagine istituzionale cui affidare, cedendola, una parte dei poteri detenuti fino ad oggi dai singoli governi, soprattutto in politica estera e nella difesa. Senza leggi federali valide dappertutto, una comune politica estera e un esercito comune, non si costruisce alcuna unità né federale, né confederale. Nell’Unione Europea attuale – che non è “dei popoli”, bensì “dei governi” – di davvero comune c’è solo la moneta. Necessaria, fondamentale: ma non sufficiente.
9. Qual è la sua opinione sullo Stato d’Israele?
Sia chiaro anzitutto che quanto ho detto circa la mia ammirazione per l’ebraismo, che avverto come profondamente intrinseco al cristianesimo, non influenza in alcun modo – a parte un’istintiva simpatia – il mio giudizio sullo stato d’Israele. Ho anzi più volte criticato, a anche con durezza, le scelte di questo o di quel governo israeliano. Ciò premesso, la mia visione favorevole a Israele necessita di una presentazione storica sintetica, ma tale da non lasciar adito a malintesi.
Lo stato d’Israele è nato da un lungo e tenace sogno, quello del movimento sionista dell’Ottocento: un movimento nazionalista come tanti ce n’erano in quell’età romantica ch’è stata l’età del nascere delle nazioni contemporanee. Tale sogno è divenuto gradualmente realtà in seguito a una serie di congiunture che si debbono conoscere, se si vuol farne seriamente la storia: il favore dell’impero ottomano che aveva tutto l’interesse, tra Otto e Novecento, a una qualificata colonizzazione dell’area palestinese (e i coloni sionisti erano ottimi: corretti, colti, pagavano puntualmente le terre che compravano e gli stipendi che corrispondevano ai lavoratori arabi, aiutavano spesso le popolazioni locali, erano ben visti); l’appoggio di una parte consistente dell’ebraismo della diaspora; il sostegno di molti governi europei.
Tuttavia, la fine dell’impero ottomano con la prima guerra mondiale, l’atteggiamento ambiguo delle potenze europee cointeressate a quell’area (Francia e soprattutto Inghilterra), il sorgere d’un nazionalismo arabo deluso dalle promesse non mantenute d’unità nazionale avanzate soprattutto dagli inglesi stessi – e ben presto tradottosi anche in un sentimento d’inimicizia nei confronti dei coloni ebrei, tra l’altro sentiti come “occidentali” complici degli inglesi, il che fra l’altro non era vero -, l’emergere di un forte e inaspettato antisemitismo politico in Europa e infine la tragedia della shoah mutarono fortemente il quadro di armonico sviluppo d’una comunità ebraica coloniale che si apprestava a cercare nuovi sbocchi istituzionali nei quali inquadrare la sua compagine. La cattiva coscienza europea dopo l’olocausto e il pericolo costituito, per le potenze occidentali, dagli stati arabi che con l’insorgere della “guerra fredda” si andavano orientando in senso sempre più occidentale, determinarono un accelerarsi della situazione: la ricerca di equilibrio fra i coloni ebrei e i residenti palestinesi – musulmani o cristiani che fossero – insediati nella zona, cedette il passo nel ’48 – dopo preoccupanti avvisaglie che già si erano avute negli Anni Venti e Trenta – a un precipitare della situazione. La comunità ebraica, tempestivamente, si eresse in “stato d’Israele”; i palestinesi, divisi e disorientati, forse anche mal consigliati, non vollero o non seppero fare altrettanto, confidando tra l’altro in una “solidarietà araba” che nel tempo si sarebbe rivelata inefficiente o fallace. Israele seppe crearsi una sua solida compagine statale e militare, anche appoggiata dalle rimesse di denaro dell’ebraismo “della diaspora” e, almeno dopo la guerra del 1967, dal costante appoggio diplomatico degli Stati Uniti che le fornì la copertura diplomatica necessaria a consentirle di disattendere quelle risoluzioni delle Nazioni Unite che le avrebbero impedito di raggiungere una continuità territoriale garantita dai “presidii” di due aree non annesse al territorio metropolitano d’Israele, bensì “occupate”, i territori galileo-samaritano-giudaici, cioè i cosiddetti “territori occupati”, addossati al Giordano (con il relativo controllo idrico), e le alture del Golan. Tutto ciò, pagando il prezzo di quello che alcuni giovani storici “revisionisti” israeliani hanno definito “il peccato originale d’Israele”: l’espulsione sistematica degli abitanti palestinesi da alcune terre, che va peraltro giudicata alla luce di un movimento qualitativamente e quantitativamente diverso ma speculare: la cacciata (senza risarcimento dei beni sequestrati) di molti ebrei, all’inizio della crisi israeliano-palestinese, dai paesi arabi nei quali essi avevano posizioni e assi patrimoniali sovente di rilievo: Egitto, Giordania, Siria, Iraq. Altro elemento d’inciampo: la “legge del ritorno”, secondo la quale qualunque ebreo del mondo (nato cioè da madre ebrea) è naturaliter cittadino d’Israele, solo che lo voglia. Se, in ipotesi assurda, tutti i circa trenta milioni di ebrei della diaspora decidessero di usufruire questa legge e rientrare in Israele, basterebbero frontiere dal Nilo all’Eufrate all’Oronte per ospitarli tutti?
Credo pertanto che oggi il diritto d’Israele a vivere e a mantenere il suo posto tra le libere nazioni del mondo sia definitivamente, irreversibilmente acquisito e innegabile: al punto che lo stesso chiedersi se esso sussista è assurdo. Ne sono sempre stato un convinto sostenitore, come ho dimostrato in tutti i miei scritti (richiamo in special modo l’Introduzione al libro edito anni fa dalla Dedalo di Bari e la monografia Gli ebrei, popolo eletto e perseguitato). Tale diritto va però corroborato con l’instaurazione di una vera e solida pace, impossibile dopo un conflitto durato ben oltre mezzo secolo senza il soddisfacimento delle legittime richieste della comunità palestinese ormai eretta in Authority amministrativa, ma non ancora in stato indipendente e sovrano. Queste richieste danno luogo a un contenzioso riassumibile in quattro punti: 1. Spartizione della città di Gerusalemme, cui né israeliani, né palestinesi vogliono né possono rinunziare (anche se in realtà i palestinesi si acconterebbero di una porzione modesta e periferica di essa; a parte, resterebbe da esaminare il problema dell’internalizzazione dei Luoghi Santi non ebraici, cioè cristiani e musulmani: che però interessa il solo ristretto perimetro della città storica); 2. Ridistribuzione del territorio isrealiano-palestinese in modo che, con modestissimi ritocchi e mantenendo a Israele i territori acquisiti dal 1948 a oggi, si possa garantire la necessaria e indispensabile continuità territoriale al futuro stato palestinese; 3. Ristabilimento di un corretto confine tra i due stati con relativa libertà di circolazione per i molti palestinesi che lavorano in Israele, eliminazione appena possibile del “muro” e soluzione del problema costituito dalle colonie ebraiche clandestine insediate in territorio palestinese; 4. Attuazione di un piano economico-finanziario di risarcimento delle famiglie tanto ebraiche quanto palestinesi che hanno perduto la casa, la terra e gli averi dal 1948 ad oggi (con relativo abbandono delle pretese di “ritorno”, comprensibili e perfino toccanti, ma inattuabili). Per l’attuazione di questo piano generale, sarebbero necessari la mediazione e l’impegno (anche economico) della comunità internazionale tutta. E’ un’esigenza costosissima, nonché lunga e difficile da attuarsi. Ma finché non l’adotteremo il teatro israeliano-palestinese sarà preda degli opposti fondamentalismi e la malapianta del terrorismo, che si alimenta del disagio nato da quella situazione, non sarà sradicata.
E’ ovvio che una franca, aperta e irreversibile accettazione del diritto d’Israele a vivere liberamente e pacificamente implica il diritto della comunità internazionale a dialogare correttamente e serenamente con essa. Israele deve accettare oggi appieno il suo ruolo di paese mediterraneo e vicino-orientale, entrando in franco e leale colloquio con i paesi confinanti e controllando con cura le tentazioni, che al suo interno sono forti, di atteggiarsi a “sentinella avanzata dell’Occidente”. Allo stato attuale delle cose, il sostegno unilaterale statunitense di cui essa ha in molti casi goduto le ha impedito di sviluppare un’attività diplomatica aperta anche in altre direzioni; e ciò, unito al fatto ch’essa è l’unica potenza nucleare di tutta l’area, ha creato uno stato di tensione, di disagio e di sospetto che non può costituire la base d’una pace durevole. Questi sono alcuni dei problemi di cui la società civile occidentale dovrebbe prendere concretamente atto, se non vuole ridurre il suo assenso o il suo dissenso nei confronti della politica israeliana a un atteggiamento non troppo dissimile da una questione di tifo calcistico. Il problema non è essere “pro” o “contro” Israele, bensì prendere atto di concrete questioni e chiedersi come potrebbero essere risolte.
giovedì 20 novembre 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
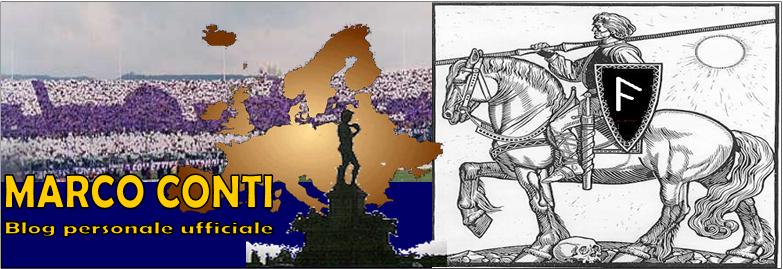




Nessun commento:
Posta un commento